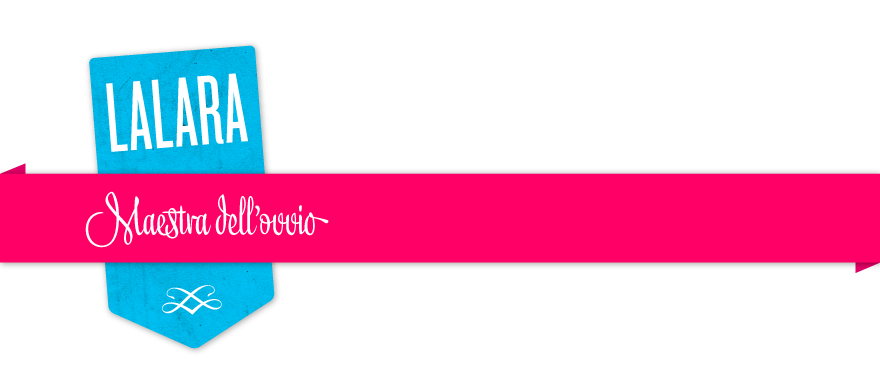Il fatto è che sono talmente abituata a produrre il solo rumore della tastiera e del mouse del computer che finisco col credere che non esista altro rumore al mondo.
E finisco col credere che quel rumore conti qualcosa.
Ma io ho una voce.
Ho un corpo.
Ho una pelle che diventa una pagina in braille da leggere a fior di dita quando qualcosa mi emoziona.
Ho braccia che sanno abbracciare e tirare pugni.
Ho gambe che corrono, scalpitano, mi portano in giro.
Sono tanto più reale quanto più mi allontano da questo schermo.
E ci trovo la vita vera, lì, lontano.
Una vita dove so scandalizzarmi davvero, muovermi davvero, partecipare davvero, gioire davvero, al netto di tasti "mi piace", commenta e colpi di mouse.
Ho l'impressione che qui davanti se ne perda un po' il senso.
Della partecipazione, dell'amicizia, della vicinanza, del "vero" - bello o brutto che sia.
E io non voglio perderne il senso. Il senso è a volte la sola cosa che mi resta.
E quando mi ritrovo poco colpita da cose che in teoria dovrebbero sconvolgermi - e quando constato che in passato l'avrebbero fatto - allora capisco che ho bisogno di disintossicazione da tutta questa sicurezza, da tutta questa comodità; capisco che ho bisogno di tornare a guardare la gente negli occhi, di berci un caffè, di comprare fiori, di tirare su la macchina e macinare chilometri solo per andare ad accarezzare una pancia nuova (forse ci metto qualche mese in più, ma arrivo), di scendere in piazza a gridare, di tirare un pugno quando serve, di vedere dal vivo lo spegnersi di candeline su una torta, di sentire il profumo di neve nell'aria, di difendere il più debole che mi è seduto accanto, di usare il cervello che mi è stato dato per qualcosa di un po' più alto della condivisione di un link.
Non voglio moralizzare niente e nessuno. Sto parlando solo per me stessa.
La partecipazione io la intendo dal vivo.
La vita io la intendo dal vivo.
28 gennaio 2012
25 gennaio 2012
Lara è uscita dal gruppo (ma soprattutto ne è mai entrata?)
Sono sempre a margine di qualcosa.
Non "marginale" e neanche "ai margini" ma è come se avessi la sensazione di non essere mai "dentro".
Così, da sempre.
Quando studiavo pianoforte io ero comunque altrove. Sapevo che era importante, sapevo che ci stavo investendo, ma non ne ero dentro come poteva esserci un qualsiasi allievo del conservatorio. Era solo un aspetto della mia vita, importante, creativo, pulsante, vitale, ma comunque solo uno dei tanti. E io guardavo quelli del conservatorio che della musica avevano fatto il centro della loro esistenza con l'invidia di chi sa che non saprà mai prendere una posizione simile nei confronti di niente.
Ogni cosa che facevo, e le cose erano tante, diventava l'alibi per non investire tutto nelle altre. Tutte-reciprocamente-verso-tutte.
Bello avere tante opzioni, tanti piccoli talenti, ma forse sarebbe meglio averne uno e su quello puntare all'eccellenza. Io no. Discreta, mediocre, approssimativa in mille cose, tutte che mi riuscivano "benino", un genio in nulla. Incapace di sceglierne una e lavorarci davvero sopra per renderla unica.
Sembravo sempre in compagnia, toccavo mille ambienti diversi, apparentemente inserita in ognuno di essi, ma di fatto - e solo io lo sapevo - ero lì davanti, mai dentro. Come all'Ikea: vedi tutti quegli ambienti meravigliosi, e ci entri, e tocchi le cose, e ti ci accomodi pure, ma sempre con la sensazione di non esserne davvero parte, di essere un elemento in movimento rispetto a quella perfezione che continuerà ad esistere a prescindere da te.
Chiunque lavori su qualcosa di cui è appassionato ha la sensazione che tutto sia racchiuso in quel contesto. Vedo Lui con le sue moto, vedo i miei colleghi con la grafica, ricordo quando lavoravo in pubblicità, o negli eventi: in quelle dieci ore passate in ufficio mi sembrava che il mondo iniziasse e finisse con i problemi di shooting, sviluppo, telecinema, consegne, allestimenti, service tecnici e regia.
Poi andavo a casa, ma con la testa stavo sempre lì, a pensare ai dettagli trascurati, a quello che avevo lasciato indietro, a ciò che avrei dovuto fare l'indomani e questo mi dava la conferma di quello che già vivevo in ufficio: tutto girava intorno a quello. Che è un "quello" mobile e varia da persona a persona, da lavoro a lavoro.
Però.
Anche in quel caso, io ero a margine. Non perchè non mi impegnassi, anzi, ma è come se facendo un po' la sostenuta, non volessi farmi prendere dentro del tutto, come se lo sposare la causa in toto mi togliesse parte di me, della mia capacità critica, del mio sguardo trasversale.
L'impegno c'era sempre ma io tenevo una posizione esterna, sollevata, che non significa "superiore" sia chiaro, semplicemente facevo in modo che il contatto tra me e il resto non fosse totale. "Non mi avrete mai del tutto", pensavo, non senza una certa presuntuosa vanteria.
Poi ho avuto i bimbi. E quello sì che è un ruolo totalizzante, almeno nel rapporto esclusivo ed escludente che ho creato con loro. Ma poi mi confronto con la società del mondobimbo e mi rendo conto che anche in quel caso io non ne sono dentro, non del tutto. Mantengo il solito distacco, chiedendomi di continuo se loro ne pagheranno mai le conseguenze.
Faccio un lavoro che potrei fare dove faccio o in altri cento posti diversi, che non è il genere di lavoro a cui una possa "appassionarsi". Lo faccio in un contesto bello pieno di gente ancor più bella, che però fa tutt'altra cosa, e il risultato di questo è che io non sono completamente integrata. Perchè non faccio quel che fanno loro. Perchè non posso capire ciò che sta alla base del loro mestiere. Perchè quello che ovviamente per loro è la centralità dell'esistenza, io da sola lo vedo come un semplice aspetto della stessa.
Esattamente come Lui e le sue moto che quando ne parla sembra che tutto il mondo giri intorno alle due ruote.
"Chi è causa del suo mal pianga se stesso", chiaramente, il mio ruzzolare qua e là è stata a suo modo una scelta di campo.
Solo che ogni tanto mi sento un po' sola.
E sOla, certo.
Vorrei tanto essere "dentro". Ecco, questa cosa vorrei.
Non "marginale" e neanche "ai margini" ma è come se avessi la sensazione di non essere mai "dentro".
Così, da sempre.
Quando studiavo pianoforte io ero comunque altrove. Sapevo che era importante, sapevo che ci stavo investendo, ma non ne ero dentro come poteva esserci un qualsiasi allievo del conservatorio. Era solo un aspetto della mia vita, importante, creativo, pulsante, vitale, ma comunque solo uno dei tanti. E io guardavo quelli del conservatorio che della musica avevano fatto il centro della loro esistenza con l'invidia di chi sa che non saprà mai prendere una posizione simile nei confronti di niente.
Ogni cosa che facevo, e le cose erano tante, diventava l'alibi per non investire tutto nelle altre. Tutte-reciprocamente-verso-tutte.
Bello avere tante opzioni, tanti piccoli talenti, ma forse sarebbe meglio averne uno e su quello puntare all'eccellenza. Io no. Discreta, mediocre, approssimativa in mille cose, tutte che mi riuscivano "benino", un genio in nulla. Incapace di sceglierne una e lavorarci davvero sopra per renderla unica.
Sembravo sempre in compagnia, toccavo mille ambienti diversi, apparentemente inserita in ognuno di essi, ma di fatto - e solo io lo sapevo - ero lì davanti, mai dentro. Come all'Ikea: vedi tutti quegli ambienti meravigliosi, e ci entri, e tocchi le cose, e ti ci accomodi pure, ma sempre con la sensazione di non esserne davvero parte, di essere un elemento in movimento rispetto a quella perfezione che continuerà ad esistere a prescindere da te.
Chiunque lavori su qualcosa di cui è appassionato ha la sensazione che tutto sia racchiuso in quel contesto. Vedo Lui con le sue moto, vedo i miei colleghi con la grafica, ricordo quando lavoravo in pubblicità, o negli eventi: in quelle dieci ore passate in ufficio mi sembrava che il mondo iniziasse e finisse con i problemi di shooting, sviluppo, telecinema, consegne, allestimenti, service tecnici e regia.
Poi andavo a casa, ma con la testa stavo sempre lì, a pensare ai dettagli trascurati, a quello che avevo lasciato indietro, a ciò che avrei dovuto fare l'indomani e questo mi dava la conferma di quello che già vivevo in ufficio: tutto girava intorno a quello. Che è un "quello" mobile e varia da persona a persona, da lavoro a lavoro.
Però.
Anche in quel caso, io ero a margine. Non perchè non mi impegnassi, anzi, ma è come se facendo un po' la sostenuta, non volessi farmi prendere dentro del tutto, come se lo sposare la causa in toto mi togliesse parte di me, della mia capacità critica, del mio sguardo trasversale.
L'impegno c'era sempre ma io tenevo una posizione esterna, sollevata, che non significa "superiore" sia chiaro, semplicemente facevo in modo che il contatto tra me e il resto non fosse totale. "Non mi avrete mai del tutto", pensavo, non senza una certa presuntuosa vanteria.
Poi ho avuto i bimbi. E quello sì che è un ruolo totalizzante, almeno nel rapporto esclusivo ed escludente che ho creato con loro. Ma poi mi confronto con la società del mondobimbo e mi rendo conto che anche in quel caso io non ne sono dentro, non del tutto. Mantengo il solito distacco, chiedendomi di continuo se loro ne pagheranno mai le conseguenze.
Faccio un lavoro che potrei fare dove faccio o in altri cento posti diversi, che non è il genere di lavoro a cui una possa "appassionarsi". Lo faccio in un contesto bello pieno di gente ancor più bella, che però fa tutt'altra cosa, e il risultato di questo è che io non sono completamente integrata. Perchè non faccio quel che fanno loro. Perchè non posso capire ciò che sta alla base del loro mestiere. Perchè quello che ovviamente per loro è la centralità dell'esistenza, io da sola lo vedo come un semplice aspetto della stessa.
Esattamente come Lui e le sue moto che quando ne parla sembra che tutto il mondo giri intorno alle due ruote.
"Chi è causa del suo mal pianga se stesso", chiaramente, il mio ruzzolare qua e là è stata a suo modo una scelta di campo.
Solo che ogni tanto mi sento un po' sola.
E sOla, certo.
Vorrei tanto essere "dentro". Ecco, questa cosa vorrei.
21 gennaio 2012
20 gennaio 2012
Facciamocene una ragione
Dobbiamo.
Dobbiamo farcene una ragione.
È inutile continuare a negare, a scalciare, a dire che non è vero, che possiamo trovare un modo di essere migliori, solo per tirare avanti ancora un giorno, uno soltanto, nella stessa piatta situazione.
Dobbiamo prendere il coraggio di ammettere che è così, che è sempre stato così, che noi non abbiamo inventato niente di nuovo, e che non siamo originali nel nostro negare l'ovvio, nascondendoci dietro a ruoli e a situazioni che ci facciano da alibi.
Dobbiamo ammettere che in fondo avevano ragione loro quando dicevano che prima o poi avremmo dovuto arrenderci all'evidenza.
Dobbiamo farcene una ragione.
Sul taccododici lo stacco di gamba è tutta un'altra cosa.
Dobbiamo farcene una ragione.
È inutile continuare a negare, a scalciare, a dire che non è vero, che possiamo trovare un modo di essere migliori, solo per tirare avanti ancora un giorno, uno soltanto, nella stessa piatta situazione.
Dobbiamo prendere il coraggio di ammettere che è così, che è sempre stato così, che noi non abbiamo inventato niente di nuovo, e che non siamo originali nel nostro negare l'ovvio, nascondendoci dietro a ruoli e a situazioni che ci facciano da alibi.
Dobbiamo ammettere che in fondo avevano ragione loro quando dicevano che prima o poi avremmo dovuto arrenderci all'evidenza.
Dobbiamo farcene una ragione.
Sul taccododici lo stacco di gamba è tutta un'altra cosa.
18 gennaio 2012
Quel giorno in cui mi giocavo tutto
Quel giorno in cui mi giocavo tutto. O così mi sembrava. C'era quell'esame da passare al quale avevo illusoriamente legato tutto il mio futuro. Professionale. Personale. Sentimentale.
Avevo vent'anni, e mi sembrava che la mia vita si dovesse decidere in quel momento. Con la violenza delle passioni di quegli anni, in cui era sempre chiaro cosa fosse dentro e cosa fuori, cosa giusto e cosa sbagliato, senza la più pallida idea dell'esistenza delle sfumature, delle alternative, dell'incognita, mi dirigevo spedita verso un futuro che, col senno di poi - mio migliore amico - posso dire grazieadio, non è diventato il mio futuro.
Ma in quel momento non contava nient'altro.
Avevo un piano perfetto, come solo una ventenne sognatrice sa avere, e tutto doveva andare bene, e tutto sarebbe combaciato alla perfezione, tutto il mio futuro si sarebbe dispiegato davanti a me con la naturalezza con cui cadono le tessere del domino. Non avevo neanche lontanamente preso in considerazione che le cose potessero andare diversamente. Avevo quella presuntuosa spocchietta di chi è cresciuta a pacche sulle spalle e tutti giù a dirmi "come sei brava". Il fallimento non era una cosa che faceva parte delle mie esperienze, o quantomeno tutte le volte riuscivo a ridimensionare il mio modo di vedere affinché qualsiasi delusione, perdita, sconfitta potesse essere rigirata a mio favore, come qualcosa di inevitabile per rendermi la meravigliosa persona che credevo di essere. Crescere nella stima è fondamentale ma dovrebbe andare a braccetto con l'insegnamento dell'autocritica. Soprattutto per una che, caratterialmente, dimostrava già di sapersi sempre perdonare tutto con una certa facilità.
E niente. Quel giorno in cui mi giocavo tutto sono andata a fare quell'esame. Mi ricordo la cartella di cuoio in cui tenevo tutti i miei appunti, il freddo, la Milano che ancora non conoscevo e che mi aspettava in tutto il suo nebbioso, splendido, umido grigiore. Treno, poi metropolitana, poi a camminare a testa alta verso il mio destino convinta che si trattasse di una semplice formalità e che la bocciatura sarebbe toccata ad altri, non certo a me.
E invece.
Sento ancora quel tonfo muto, quel battito a salve che ha fatto il mio cuore all'uscita dei quadri. "NON AMMESSA", due paroline semplici in rosso che non mi davano accesso non solo alla fase successiva dell'esame ma a tutto il sognante quadretto di vita felice che mi ero figurata.
Con la moderazione che mi contraddistingue, di cui ora riesco a riprodurre solo una pallida versione, pensavo che la mia vita fosse semplicemente finita. Ero totalmente impreparata a qualsiasi alternativa, non sapevo scegliere nient'altro, non sapevo decidere cosa fare di me.
E in fondo, un po', mi capisco: per una volta nella vita sapevo cosa volevo, invece di fare lo slalom tra le certezze dei miei "non voglio", e in quell'unica volta le cose non sono andate come speravo.
Scrivevo anche allora (in uno stile più anarchico-melò-depressivo di adesso).
Su fogli bianchi disordinati come me, come i miei sentimenti, come quella vita a cui non sapevo più dare una forma. Passavo le mie giornate, apatica, senza pensare a nulla, tra il letto e il frigorifero con la musica alta in cuffia; il mio amore che mi trattava come un oggettino di cristallo blu, senza sapere più come maneggiarmi e, probabilmente, cosa farsene di quell'involucro vuoto e senza entusiasmo che ero diventata.
Di riprovarci non se ne parlava neanche: la ristrutturazione del fallimento aveva fatto sì che io dipingessi come inadatta a me quella strada che non avevo potuto prendere, senza tuttavia essere in grado di sceglierne nessun'altra.
E lì i miei genitori hanno fatto una cosa immensa, che ovviamente avrei recriminato loro per i due anni successivi: mi hanno messo su una strada, decidendo per me, sulla base di quello che sapevano essere le mie inclinazioni. E ci hanno preso. Avevano scelto per me, prendendomi di punta, rischiando che io li odiassi per quello e diventando il capro espiatorio per qualsiasi difficoltà futura - non importava: tutto andava meglio della mia immobilità. Ci sono gesti che solo i genitori sanno fare.
Ho detestato molte cose di quella strada, molti momenti di solitudine, alcuni esami, alcune cose di cui non importava niente. Ma dopo, col senno di poi - mio migliore amico, ho capito che era qualcosa che mi piaceva. E molto. Non che servisse a darmi un'idea di chi fossi, ma mi piaceva.
È cambiato tutto da quel giorno in cui mi giocavo tutto. Ho cambiato amori, amici, città, abitudini, ho iniziato a lavorare e a ruzzolare qui e là, cercando di volta in volta di fare delle scelte giuste, con la consapevolezza che nessuna sarebbe stata davvero definitiva. E che il fallimento faceva parte delle opzioni del provarci.
Questo era il mio limite e la mia forza insieme.
Perché schiantarsi faceva male ma non potevo certo fermarmi per qualche livido.
Ogni tanto, in stile sliding doors, vorrei sapere come sarebbe andata a finire se. Me lo chiedo di tante cose, e quel giorno in cui mi giocavo tutto è solo la prima fra tutte.
Poi guardo la vita che ho e col senno di poi vorrei solo aver fatto meno casino e aver detto più "grazie" nelle direzioni giuste.
Ma si sa, sono fatta così.
Avevo vent'anni, e mi sembrava che la mia vita si dovesse decidere in quel momento. Con la violenza delle passioni di quegli anni, in cui era sempre chiaro cosa fosse dentro e cosa fuori, cosa giusto e cosa sbagliato, senza la più pallida idea dell'esistenza delle sfumature, delle alternative, dell'incognita, mi dirigevo spedita verso un futuro che, col senno di poi - mio migliore amico - posso dire grazieadio, non è diventato il mio futuro.
Ma in quel momento non contava nient'altro.
Avevo un piano perfetto, come solo una ventenne sognatrice sa avere, e tutto doveva andare bene, e tutto sarebbe combaciato alla perfezione, tutto il mio futuro si sarebbe dispiegato davanti a me con la naturalezza con cui cadono le tessere del domino. Non avevo neanche lontanamente preso in considerazione che le cose potessero andare diversamente. Avevo quella presuntuosa spocchietta di chi è cresciuta a pacche sulle spalle e tutti giù a dirmi "come sei brava". Il fallimento non era una cosa che faceva parte delle mie esperienze, o quantomeno tutte le volte riuscivo a ridimensionare il mio modo di vedere affinché qualsiasi delusione, perdita, sconfitta potesse essere rigirata a mio favore, come qualcosa di inevitabile per rendermi la meravigliosa persona che credevo di essere. Crescere nella stima è fondamentale ma dovrebbe andare a braccetto con l'insegnamento dell'autocritica. Soprattutto per una che, caratterialmente, dimostrava già di sapersi sempre perdonare tutto con una certa facilità.
E niente. Quel giorno in cui mi giocavo tutto sono andata a fare quell'esame. Mi ricordo la cartella di cuoio in cui tenevo tutti i miei appunti, il freddo, la Milano che ancora non conoscevo e che mi aspettava in tutto il suo nebbioso, splendido, umido grigiore. Treno, poi metropolitana, poi a camminare a testa alta verso il mio destino convinta che si trattasse di una semplice formalità e che la bocciatura sarebbe toccata ad altri, non certo a me.
E invece.
Sento ancora quel tonfo muto, quel battito a salve che ha fatto il mio cuore all'uscita dei quadri. "NON AMMESSA", due paroline semplici in rosso che non mi davano accesso non solo alla fase successiva dell'esame ma a tutto il sognante quadretto di vita felice che mi ero figurata.
Con la moderazione che mi contraddistingue, di cui ora riesco a riprodurre solo una pallida versione, pensavo che la mia vita fosse semplicemente finita. Ero totalmente impreparata a qualsiasi alternativa, non sapevo scegliere nient'altro, non sapevo decidere cosa fare di me.
E in fondo, un po', mi capisco: per una volta nella vita sapevo cosa volevo, invece di fare lo slalom tra le certezze dei miei "non voglio", e in quell'unica volta le cose non sono andate come speravo.
Scrivevo anche allora (in uno stile più anarchico-melò-depressivo di adesso).
Su fogli bianchi disordinati come me, come i miei sentimenti, come quella vita a cui non sapevo più dare una forma. Passavo le mie giornate, apatica, senza pensare a nulla, tra il letto e il frigorifero con la musica alta in cuffia; il mio amore che mi trattava come un oggettino di cristallo blu, senza sapere più come maneggiarmi e, probabilmente, cosa farsene di quell'involucro vuoto e senza entusiasmo che ero diventata.
Di riprovarci non se ne parlava neanche: la ristrutturazione del fallimento aveva fatto sì che io dipingessi come inadatta a me quella strada che non avevo potuto prendere, senza tuttavia essere in grado di sceglierne nessun'altra.
E lì i miei genitori hanno fatto una cosa immensa, che ovviamente avrei recriminato loro per i due anni successivi: mi hanno messo su una strada, decidendo per me, sulla base di quello che sapevano essere le mie inclinazioni. E ci hanno preso. Avevano scelto per me, prendendomi di punta, rischiando che io li odiassi per quello e diventando il capro espiatorio per qualsiasi difficoltà futura - non importava: tutto andava meglio della mia immobilità. Ci sono gesti che solo i genitori sanno fare.
Ho detestato molte cose di quella strada, molti momenti di solitudine, alcuni esami, alcune cose di cui non importava niente. Ma dopo, col senno di poi - mio migliore amico, ho capito che era qualcosa che mi piaceva. E molto. Non che servisse a darmi un'idea di chi fossi, ma mi piaceva.
È cambiato tutto da quel giorno in cui mi giocavo tutto. Ho cambiato amori, amici, città, abitudini, ho iniziato a lavorare e a ruzzolare qui e là, cercando di volta in volta di fare delle scelte giuste, con la consapevolezza che nessuna sarebbe stata davvero definitiva. E che il fallimento faceva parte delle opzioni del provarci.
Questo era il mio limite e la mia forza insieme.
Perché schiantarsi faceva male ma non potevo certo fermarmi per qualche livido.
Ogni tanto, in stile sliding doors, vorrei sapere come sarebbe andata a finire se. Me lo chiedo di tante cose, e quel giorno in cui mi giocavo tutto è solo la prima fra tutte.
Poi guardo la vita che ho e col senno di poi vorrei solo aver fatto meno casino e aver detto più "grazie" nelle direzioni giuste.
Ma si sa, sono fatta così.
15 gennaio 2012
Il taglio sul ginocchio
Sono cresciuta in un condominio, uno di quei palazzi alti alti che erano quanto di più lontano dal sogno brianzolo dei miei genitori di una casa indipendente. Ma per me e mio fratello è stato il paradiso. L'intero complesso era costituito da due torri di otto piani più altre varie palazzine più basse e in ogni appartamento - e di appartamenti ce n'erano veramente tanti - c'era almeno un bambino.
Uno squadrone.
Gli spazi comuni comprendevano centinaia e centinaia di metri quadri di giardino, oltre ad una serie di portici al pian terreno di ogni palazzo perfetti per le giornate di pioggia. Il giardino, di quelli che al giorno d'oggi te li sogni, era ordinato, pulito, ben illuminato anche di sera, suddiviso da una serie di vialetti "ciclabili" e punteggiato di isole alberate con panchine in cemento dove chiacchierare, giocare, disegnare e dove da piccoli andavamo di nascosto a sbirciare i fratelli e le sorelle maggiori che si appartavano con i fidanzatini di turno - bleah, si baciano con la lingua (seee, vabbè...).
C'era un prato grande e visibile da ogni palazzo che dopo una serie di delibere in assemblea condominiale, e dopo la nostra occupazione spontanea, fu destinato al gioco dei bambini, quindi ufficialmente nostro. Era un quadrato d'erba con in mezzo una specie di griglia di cinque metri per cinque che serviva da sfiato per i box sottostanti, griglia su cui tutti abbiamo grattugiato le ginocchia almeno una volta al punto da considerare quel momento il vero ingresso nel mondocortile - il battesimo della grata.
Il tempo allora era diviso tra scuola e gioco, e dopo i compiti e la merenda si spariva in cortile a giocare con la certezza di trovare sempre qualcuno, se non proprio tutti. All'ora di cena le mamme si affacciavano a turno al balcone a gridare i nomi dei propri bambini - ancora un attimo ti prego! ho detto subito.
E poi giù ancora, in estate, finché non diventava buio, si accendevano i piccoli lampioni tondi e gli annaffiatoi automatici e casualmente ci finivamo dentro, inzaccherati dalla testa ai piedi "non so come sia potuto succedere, mamma, davvero" (ma certo).
Giocavamo a palla base, all'elastico, a pallavolo, a calcio con le porte segnalate dalle felpe di qualcuno, sempre insieme, maschi e femmine, e i pattini e le corse in bicicletta e nascondino-a-squadre perchè su una superficie così estesa non era possibile mettere una sola persona contro tutti (e il "liberatutti" non valeva mai). C'erano gatti da adottare e nutrire, c'erano spettacoli da preparare, e l'hulahop, le staffette e la corda da saltare.
C'erano i deboli che andavano difesi, c'erano quelli che "se non mi dai il rigore porto via il pallone", c'erano i bulletti, le smorfiose, quelli che frignavano, quelli che cercavano di mettere ordine e tutti eravamo a turno un po' di tutto. C'era quella gestione indipendente da parte dei bambini, non abbandonati ma lasciati liberi di trovare una soluzione e di mediare a qualsiasi situazione.
Quando poi andavamo a scuola e c'era il bulletto di turno, ci trovavamo a gestire una cosa che per noi non era certo una novità, la fighetta, il prepotente, il piccolino da difendere, le alleanze da costruire e quelle da smontare. Il cortile ci aveva insegnato la socialità, le regole, il tempismo nell'alzare la cresta e nell'abbassarla, la necessità di chiedere scusa o di pretenderlo, gestivamo una varietà di sentimenti e di situazioni che avevamo già sperimentato nel nostro microcosmo recintato, senza alcuna ingerenza degli adulti, senza neanche lontanamente pensare che qualche "grande" dovesse intervenire.
I tempi sono cambiati.
Sono cambiati i telegiornali e le notizie che ci danno.
Fatto sta che io non sarei in grado di lasciare Lee e Roo a giocare in un qualsiasi cortile senza averli sott'occhio ogni minuto. E la conseguenza è che loro vivono esclusivamente la socialità mediata dalle maestre all'asilo e quella sotto l'occhio vigile di mille madri-che-te-le-raccomando (categoria in cui mi inserisco a pieno titolo) del parchetto.
Ma mancherà loro sempre uno spazio veramente indipendente dove sperimentare l'offesa, l'esclusione, la parzialità, il branco, l'appartenenza, la diplomazia, l'alleanza temporanea per il raggiungimento di uno scopo comune fosse anche solo quello di fare sì di arrivare alla fine del pomeriggio a giocare a pallone senza che nessuno se lo porti via.
Credo sia una gran perdita, a maggior ragione se quello che hanno guadagnato è di fingere di giocare a calcio con una console in mano davanti alla tivù.
Di recente al matrimonio di un'amica comune, ci siamo ritrovati noi ex bambini del condominio, lontani, grandi, tutti con le proprie vite apparecchiate o in fase di. Ci siamo sorrisi e abbracciati e guardati e abbiamo constatato la fine di quella confidenza spontanea a base di palloni e pattini a rotelle.
E poi ci siamo guardate, noi con le gonne svolazzanti più o meno corte, e l'abbiamo visto, quel segno, quello dell'appartenenza a quel periodo incantato, quel taglio diagonale sul ginocchio di ognuna di noi che testimonia "Io c'ero".
Un sorriso complice, e poi via.
Uno squadrone.
Gli spazi comuni comprendevano centinaia e centinaia di metri quadri di giardino, oltre ad una serie di portici al pian terreno di ogni palazzo perfetti per le giornate di pioggia. Il giardino, di quelli che al giorno d'oggi te li sogni, era ordinato, pulito, ben illuminato anche di sera, suddiviso da una serie di vialetti "ciclabili" e punteggiato di isole alberate con panchine in cemento dove chiacchierare, giocare, disegnare e dove da piccoli andavamo di nascosto a sbirciare i fratelli e le sorelle maggiori che si appartavano con i fidanzatini di turno - bleah, si baciano con la lingua (seee, vabbè...).
C'era un prato grande e visibile da ogni palazzo che dopo una serie di delibere in assemblea condominiale, e dopo la nostra occupazione spontanea, fu destinato al gioco dei bambini, quindi ufficialmente nostro. Era un quadrato d'erba con in mezzo una specie di griglia di cinque metri per cinque che serviva da sfiato per i box sottostanti, griglia su cui tutti abbiamo grattugiato le ginocchia almeno una volta al punto da considerare quel momento il vero ingresso nel mondocortile - il battesimo della grata.
Il tempo allora era diviso tra scuola e gioco, e dopo i compiti e la merenda si spariva in cortile a giocare con la certezza di trovare sempre qualcuno, se non proprio tutti. All'ora di cena le mamme si affacciavano a turno al balcone a gridare i nomi dei propri bambini - ancora un attimo ti prego! ho detto subito.
E poi giù ancora, in estate, finché non diventava buio, si accendevano i piccoli lampioni tondi e gli annaffiatoi automatici e casualmente ci finivamo dentro, inzaccherati dalla testa ai piedi "non so come sia potuto succedere, mamma, davvero" (ma certo).
Giocavamo a palla base, all'elastico, a pallavolo, a calcio con le porte segnalate dalle felpe di qualcuno, sempre insieme, maschi e femmine, e i pattini e le corse in bicicletta e nascondino-a-squadre perchè su una superficie così estesa non era possibile mettere una sola persona contro tutti (e il "liberatutti" non valeva mai). C'erano gatti da adottare e nutrire, c'erano spettacoli da preparare, e l'hulahop, le staffette e la corda da saltare.
C'erano i deboli che andavano difesi, c'erano quelli che "se non mi dai il rigore porto via il pallone", c'erano i bulletti, le smorfiose, quelli che frignavano, quelli che cercavano di mettere ordine e tutti eravamo a turno un po' di tutto. C'era quella gestione indipendente da parte dei bambini, non abbandonati ma lasciati liberi di trovare una soluzione e di mediare a qualsiasi situazione.
Quando poi andavamo a scuola e c'era il bulletto di turno, ci trovavamo a gestire una cosa che per noi non era certo una novità, la fighetta, il prepotente, il piccolino da difendere, le alleanze da costruire e quelle da smontare. Il cortile ci aveva insegnato la socialità, le regole, il tempismo nell'alzare la cresta e nell'abbassarla, la necessità di chiedere scusa o di pretenderlo, gestivamo una varietà di sentimenti e di situazioni che avevamo già sperimentato nel nostro microcosmo recintato, senza alcuna ingerenza degli adulti, senza neanche lontanamente pensare che qualche "grande" dovesse intervenire.
I tempi sono cambiati.
Sono cambiati i telegiornali e le notizie che ci danno.
Fatto sta che io non sarei in grado di lasciare Lee e Roo a giocare in un qualsiasi cortile senza averli sott'occhio ogni minuto. E la conseguenza è che loro vivono esclusivamente la socialità mediata dalle maestre all'asilo e quella sotto l'occhio vigile di mille madri-che-te-le-raccomando (categoria in cui mi inserisco a pieno titolo) del parchetto.
Ma mancherà loro sempre uno spazio veramente indipendente dove sperimentare l'offesa, l'esclusione, la parzialità, il branco, l'appartenenza, la diplomazia, l'alleanza temporanea per il raggiungimento di uno scopo comune fosse anche solo quello di fare sì di arrivare alla fine del pomeriggio a giocare a pallone senza che nessuno se lo porti via.
Credo sia una gran perdita, a maggior ragione se quello che hanno guadagnato è di fingere di giocare a calcio con una console in mano davanti alla tivù.
Di recente al matrimonio di un'amica comune, ci siamo ritrovati noi ex bambini del condominio, lontani, grandi, tutti con le proprie vite apparecchiate o in fase di. Ci siamo sorrisi e abbracciati e guardati e abbiamo constatato la fine di quella confidenza spontanea a base di palloni e pattini a rotelle.
E poi ci siamo guardate, noi con le gonne svolazzanti più o meno corte, e l'abbiamo visto, quel segno, quello dell'appartenenza a quel periodo incantato, quel taglio diagonale sul ginocchio di ognuna di noi che testimonia "Io c'ero".
Un sorriso complice, e poi via.
12 gennaio 2012
Prima bisogna esprimere un desiderio
Un anno fa ho cominciato a scrivere qui. Ho iniziato in sordina, come una che entra in punta di piedi in uno spazio che non è ancora suo anche se c'è scritto il nome sul campanello. È stato come prendere confidenza con una casa nuova: devi capire com'è fatta prima di imparare a muovertici dentro ad occhi chiusi.
Ho tirato matto l'architetto di questa casa nuova con richieste, dubbi, disastri tecnici, domande, maddai, e certamente gli devo molto dell'essere arrivata fino a qui.
Se rileggo quei primi post mi faccio tenerezza da sola perché non avevo capito ancora che tono di voce dare loro, non sapevo se scrivere per me o per l'esterno - cosa che non ho capito bene neanche ora, forse un misto tra le due cose, avevo paura della mia stessa ombra, parlavo sottovoce da persona timida (sì, timida, finitela di ridere voi là in fondo, io sono timida) che ha paura di dire la sua, e ha ancora più paura della violenza dell'eventuale reazione.
Si cresce in posti e in modi che uno non si aspetta.
Sono cresciuta anche qui dentro, o meglio è cresciuto il modo che ho di concepire questo spazio.
Che ora è a tutti gli effetti una casa, di quelle sempre un po' incasinate, piene di oggetti, di colori, di musica, di voci, di momenti da risate immense, di noia, di confidenze sul divano, di apatia e di lenti a lume di candela.
Ho scritto 215 post in un anno, un'infinità davvero se penso che spesso sono stata tentata di chiuderlo e in un paio di occasioni ci sono andata veramente vicina.
Ora non lo so che cosa sarà di questo posto, non so che genere di evoluzione dargli, se sarà un'evoluzione o un'involuzione, se è già stato scritto tutto o se ancora c'è da dire, un momento sono una rockstar entusiasta e il momento dopo sono come Forrest un po' stanchina.
Per oggi mi accontento di festeggiarne il compleanno come lo festeggeresti di un amico che ti sta a sentire sempre, anche quando gli ripeti per la milionesima volta la stessa cosa, che ti raccoglie pensieri, parole, opere e omissioni e ti aiuta a rimettere ordine nei cassetti solo per il fatto che c'è, esiste e ti dà spazio, anche per recitare la parte che vuoi sostenere quel giorno.
Quindi, buon compleanno blog.
E grazie a tutti quelli che sono passati di qui.
Ho tirato matto l'architetto di questa casa nuova con richieste, dubbi, disastri tecnici, domande, maddai, e certamente gli devo molto dell'essere arrivata fino a qui.
Se rileggo quei primi post mi faccio tenerezza da sola perché non avevo capito ancora che tono di voce dare loro, non sapevo se scrivere per me o per l'esterno - cosa che non ho capito bene neanche ora, forse un misto tra le due cose, avevo paura della mia stessa ombra, parlavo sottovoce da persona timida (sì, timida, finitela di ridere voi là in fondo, io sono timida) che ha paura di dire la sua, e ha ancora più paura della violenza dell'eventuale reazione.
Si cresce in posti e in modi che uno non si aspetta.
Sono cresciuta anche qui dentro, o meglio è cresciuto il modo che ho di concepire questo spazio.
Che ora è a tutti gli effetti una casa, di quelle sempre un po' incasinate, piene di oggetti, di colori, di musica, di voci, di momenti da risate immense, di noia, di confidenze sul divano, di apatia e di lenti a lume di candela.
Ho scritto 215 post in un anno, un'infinità davvero se penso che spesso sono stata tentata di chiuderlo e in un paio di occasioni ci sono andata veramente vicina.
Ora non lo so che cosa sarà di questo posto, non so che genere di evoluzione dargli, se sarà un'evoluzione o un'involuzione, se è già stato scritto tutto o se ancora c'è da dire, un momento sono una rockstar entusiasta e il momento dopo sono come Forrest un po' stanchina.
Per oggi mi accontento di festeggiarne il compleanno come lo festeggeresti di un amico che ti sta a sentire sempre, anche quando gli ripeti per la milionesima volta la stessa cosa, che ti raccoglie pensieri, parole, opere e omissioni e ti aiuta a rimettere ordine nei cassetti solo per il fatto che c'è, esiste e ti dà spazio, anche per recitare la parte che vuoi sostenere quel giorno.
Quindi, buon compleanno blog.
E grazie a tutti quelli che sono passati di qui.
7 gennaio 2012
Bussole
Io vi ammiro voi che sapete sempre dove stare. E dove andare.
Vi invidio, che sapete sempre cosa dire, fare, baciare, lettera e testamento.
Ma come cazzo fate ad avere sempre una risposta certa per tutto, me lo dite?
Ma che è successo, ero assente quando distribuivano la verità da tenere sempre pronta in tasca?
Io faccio lo slalom tra domande, dubbi, tentativi, botte di fortuna e sgomitate varie.
Vorrei essere come voi, su quei vostri gradini altissimi di podio, tutti vestiti di sicurezza e con la medaglia d'oro in bella vista - "sempre in posa per una foto che nessuno sta scattando" (cit.) - a fare psicologia sulle vite di chiunque tranne la vostra.
E invece sto qui seduta, metto su della musica bella, sorrido, mangio cioccolata e aspetto che cambi il vento-un raggio di sole-un bacio.
Non necessariamente in quest'ordine.
Vi invidio, che sapete sempre cosa dire, fare, baciare, lettera e testamento.
Ma come cazzo fate ad avere sempre una risposta certa per tutto, me lo dite?
Ma che è successo, ero assente quando distribuivano la verità da tenere sempre pronta in tasca?
Io faccio lo slalom tra domande, dubbi, tentativi, botte di fortuna e sgomitate varie.
Vorrei essere come voi, su quei vostri gradini altissimi di podio, tutti vestiti di sicurezza e con la medaglia d'oro in bella vista - "sempre in posa per una foto che nessuno sta scattando" (cit.) - a fare psicologia sulle vite di chiunque tranne la vostra.
E invece sto qui seduta, metto su della musica bella, sorrido, mangio cioccolata e aspetto che cambi il vento-un raggio di sole-un bacio.
Non necessariamente in quest'ordine.
4 gennaio 2012
Mi faccia il totale (delle parole scritte)
Sta per arrivare un compleanno importante (non propriamente mio anche se un po' mio), uno di quelli che ti obbligano a "fare il punto" e rivedere quello che hai fatto, scritto, pensato, disegnato.
E quindi eccomi qui, con in mano i sassi avanzati dopo la strada fatta e a guardare quelli che ho lasciato indietro.
Ho presentato la mia amica A., ho scritto del mio PrimoAmore, ho scritto di storie che mi hanno fatto male ma sono andata avanti e di ricordi che non lascio andare via.
Ho pensato molto alla mia Milano, ne ho scritto diverse volte.
Ho fatto coming out su una serie di meccanismi psicologici che non (e non sono ancora tutti) e sulle "vite degli altri".
Ho parlato di me.
E ovviamente tanto, tantissimo di Lee e Roo, e del quotidiano eroico e divertente che ne viene fuori.
Ho perlopiù tenuto fuori Lui, se non sottoforma di quotidianità spesso divertente, proteggendolo come quel genere di segreti che le parole non possono spiegare.
Ho viaggiato nei ricordi. Tanti ricordi.
Mi sono arrabbiata molto.
Ho sorriso pensando all'adolescente che ero e ancor più a quella che sono, e alle mie amiche "esercito della salvezza".
Dopo alcune riflessioni, ho iniziato a correre.
Sono stata a Roma, al mare, ho litigato coi miei capelli, mi sono accartocciata parecchio.
È stato un (quasi) anno intenso.
E quindi eccomi qui, con in mano i sassi avanzati dopo la strada fatta e a guardare quelli che ho lasciato indietro.
Ho presentato la mia amica A., ho scritto del mio PrimoAmore, ho scritto di storie che mi hanno fatto male ma sono andata avanti e di ricordi che non lascio andare via.
Ho pensato molto alla mia Milano, ne ho scritto diverse volte.
Ho fatto coming out su una serie di meccanismi psicologici che non (e non sono ancora tutti) e sulle "vite degli altri".
Ho parlato di me.
E ovviamente tanto, tantissimo di Lee e Roo, e del quotidiano eroico e divertente che ne viene fuori.
Ho perlopiù tenuto fuori Lui, se non sottoforma di quotidianità spesso divertente, proteggendolo come quel genere di segreti che le parole non possono spiegare.
Ho viaggiato nei ricordi. Tanti ricordi.
Mi sono arrabbiata molto.
Ho sorriso pensando all'adolescente che ero e ancor più a quella che sono, e alle mie amiche "esercito della salvezza".
Dopo alcune riflessioni, ho iniziato a correre.
Sono stata a Roma, al mare, ho litigato coi miei capelli, mi sono accartocciata parecchio.
È stato un (quasi) anno intenso.
3 gennaio 2012
Recrudescenze
Ci sono ruoli che poi si è talmente bravi ad interpretare che finiscono per restare attaccati addosso come magliette bagnate. Ci sono maschere che si portano, per facciata, per difesa, per dissimulazione, che aderiscono talmente bene ad un volto che non sai più se siano maschere o il volto stesso. Ci sono sensazioni che si cercano di nascondere o al contrario di enfatizzare, magari per nasconderne delle altre, e che finiscono per diventare protagoniste al punto che le altre - quelle vere - non riesci più a vederle.
Ci sono strade che si srotolano sotto i piedi che neanche te ne accorgi e ci sei già sopra, ma il più delle volte puoi sempre decidere se percorrerle o cercarne altre. O se stare ferma un po'.
Ci sono cose di cui vorresti continuare a parlare, a parlare e a parlare ancora per mantenerle vive e vere, perchè non riesci a stare a guardare, zitta, mentre ti sbiadiscono davanti. O mentre, semplicemente, cambiano.
Ci sono persone che hai sempre la sensazione che quando sei triste loro un po' ci godano e da queste persone bisogna prendere il largo. Anche se sono amiche. Soprattutto se sono amiche.
Ci sono canzoni che non si possono sentire perchè dentro ci sono giorni che non si possono ricordare.
Ci sono posti in cui si è stati anche se non ci si è mai stati. E posti in cui si è stati tante volte che non esistono più per noi.
Ci sono abitudini-persone-tempi che ti restano incollati dentro dei gesti che non sai più fare.
Ci sono lenti che non sono mai stati ballati.
Ci sono rapporti tra persone che prima erano sinfonie e ora sono partite a scacchi in cui uno esce inevitabilmente sbriciolato.
Ci sono quelle volte in cui non puoi che pentirti di essere stata così sinceramente vulnerabile. Per la precisione, tutte.
Ci sono colori "pastello" e io odio i colori pastello.
Ci sono momenti che vorresti urlare e poi crollare e invece finisce sempre allo stesso modo: taci.
E allora corri.
Sì, il mio epitaffio sarà: sindrome pre-mestruale.
Ci sono strade che si srotolano sotto i piedi che neanche te ne accorgi e ci sei già sopra, ma il più delle volte puoi sempre decidere se percorrerle o cercarne altre. O se stare ferma un po'.
Ci sono cose di cui vorresti continuare a parlare, a parlare e a parlare ancora per mantenerle vive e vere, perchè non riesci a stare a guardare, zitta, mentre ti sbiadiscono davanti. O mentre, semplicemente, cambiano.
Ci sono persone che hai sempre la sensazione che quando sei triste loro un po' ci godano e da queste persone bisogna prendere il largo. Anche se sono amiche. Soprattutto se sono amiche.
Ci sono canzoni che non si possono sentire perchè dentro ci sono giorni che non si possono ricordare.
Ci sono posti in cui si è stati anche se non ci si è mai stati. E posti in cui si è stati tante volte che non esistono più per noi.
Ci sono abitudini-persone-tempi che ti restano incollati dentro dei gesti che non sai più fare.
Ci sono lenti che non sono mai stati ballati.
Ci sono rapporti tra persone che prima erano sinfonie e ora sono partite a scacchi in cui uno esce inevitabilmente sbriciolato.
Ci sono quelle volte in cui non puoi che pentirti di essere stata così sinceramente vulnerabile. Per la precisione, tutte.
Ci sono colori "pastello" e io odio i colori pastello.
Ci sono momenti che vorresti urlare e poi crollare e invece finisce sempre allo stesso modo: taci.
E allora corri.
Sì, il mio epitaffio sarà: sindrome pre-mestruale.
1 gennaio 2012
Capodanno
Capodanno #1
Ore 7 - tutti svegli. Cioè svegli quelli bassi e noi di conseguenza. Presenza scenica - consapevolezza del proprio ruolo nel mondo - brillantezza di vedute non equamente distribuite tra bassi (tantissimo di tutto) e alti (molto ma molto meno). Lui entra in cucina e mi trova con una tazza di caffè in mano seduta davanti a una cipolla, del brandy, carne non meglio identificata e acciughe.
Ore 7 - tutti svegli. Cioè svegli quelli bassi e noi di conseguenza. Presenza scenica - consapevolezza del proprio ruolo nel mondo - brillantezza di vedute non equamente distribuite tra bassi (tantissimo di tutto) e alti (molto ma molto meno). Lui entra in cucina e mi trova con una tazza di caffè in mano seduta davanti a una cipolla, del brandy, carne non meglio identificata e acciughe.
- All'anima della colazione dei campioni...
- Mi viene da vomitare.
- Buon anno anche a te.
Capodanno #2
Cambio musica nell'iPod, cambio libri da leggere, cambio colori amici, cambio abitudini tecnologiche, cambio prospettiva. Non è che queste nuove cose siano migliori, sono solo diverse per il momento. Che siano migliori o meno lo saprò dire tra 366 giorni.
Capodanno #3
A me questo periodo dell'anno mi mette un'ansia che non so spiegare. È come se dovessi prendere confidenza con qualcosa di nuovo che non conosco, chè il "vecchio" e il "familiare" sono andati, e tutte le volte ho paura dell'incognita, del non esserne capace, come se questi primi giorni con la data che fai fatica a fare entrare nelle dita, e tutte le volte digiti e scrivi il vecchio anno (minimo per un mese), fossero fatti di qualcosa di diverso dai precedenti. E a me questa cosa a-i-u-t-o. E tutte le volte io speriamo che me la cavo.
Nuove pagine bianche da scrivere a suon di giorni, emozioni, vita.
Altro giro, altra corsa.
Alzo il volume della musica e si va.
Capodanno #2
Cambio musica nell'iPod, cambio libri da leggere, cambio colori amici, cambio abitudini tecnologiche, cambio prospettiva. Non è che queste nuove cose siano migliori, sono solo diverse per il momento. Che siano migliori o meno lo saprò dire tra 366 giorni.
Capodanno #3
A me questo periodo dell'anno mi mette un'ansia che non so spiegare. È come se dovessi prendere confidenza con qualcosa di nuovo che non conosco, chè il "vecchio" e il "familiare" sono andati, e tutte le volte ho paura dell'incognita, del non esserne capace, come se questi primi giorni con la data che fai fatica a fare entrare nelle dita, e tutte le volte digiti e scrivi il vecchio anno (minimo per un mese), fossero fatti di qualcosa di diverso dai precedenti. E a me questa cosa a-i-u-t-o. E tutte le volte io speriamo che me la cavo.
Nuove pagine bianche da scrivere a suon di giorni, emozioni, vita.
Altro giro, altra corsa.
Alzo il volume della musica e si va.
Iscriviti a:
Post (Atom)